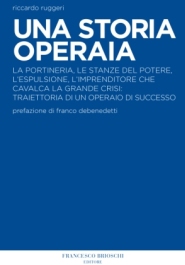
Una storia operaia
di Riccardo Ruggeri
Francesco Briochi Editore, 2009
pp. 230
La storia è, classicamente, storia di fatti. Oppure biografia, storia di «vite di uomini illustri». O ancora autobiografia, storia della propria vita e dei fatti di cui si è stati personalmente partecipi.
Questa storia è diversa, costruita com’è da ritratti di persone incontrate. Chi è il protagonista? L’autore in quanto è lui presente in ognuno di quegli incontri? O l’altro, i personaggi incontrati e rappresentati?
È una storia precisa, tempi, luoghi, ambienti sono ben definiti; ma può essere percorsa in molti modi, in molti modi si possono collegare i vari ritratti. L’ordine solo approssimativamente cronologico, con cui si susseguono, suggerisce associazioni d’idee che rivelano molti piani di interesse. Questo modo di raccontare una storia attraverso il suo riflettersi nei ritratti di persone, il suo riecheggiare nelle frasi memorizzate durante un incontro, ha per risultato una sorta di indirettezza, come se l’autore in quei ritratti si rispecchiasse in quelle parole si riascoltasse.
Avendo a disposizione una molteplicità di percorsi di lettura, il lettore alla fine si chiede perfino quale storia l’autore abbia voluto raccontare. Quella della propria vita o quella di una famiglia? Quella della Fiat, dalla fonderia del nonno alla multinazionale del nipote? Oppure questa è una storia di stili di management, dal ferreo centralismo vallettiano, al diafano policentrismo dei consulenti? O è la storia di un pezzo di società torinese, da «quel variegato grumo di vite che si è agitato, a cavallo degli anni Quaranta, al civico 9 di piazza Vittorio Veneto», alle promiscue contiguità della Torino di oggi, tra la razionalità delle nuove «spine» e il degrado di alcuni quartieri?
Chi sceglie di raccontare una storia attraverso le persone incontrate ha evidentemente, per le persone, un interesse molto particolare. C’è sì il desiderio di capirle e di coglierne l’individualità, ma c’è anche l’attenzione all’intersezione tra due vite, due interessi, due modi di guardare il mondo. C’è continuità tra il ragazzino che dalla portineria osserva gli andirivieni dello «spaccato di un perfetto modello di integrazione sociale fra le varie classi», e il manager di successo che si attarda a «affabulare» in trattoria con il capo del Sismi perché vi riconosce «la simpatia umana E…] trattenuta, presente spesso negli uomini delle marche di frontiera».
Visti dalla portineria, gli «erano tutti antipatici, padroni e servi». Crescendo avrà simpatie e antipatie, entusiasmi e delusioni, ammirazione e dissenso. Rari ma profondi disprezzi, come quello per gli «intolleranti, a parole filo operai, in realtà borghesi filo se stessi, profumati al muschio. Resterà sempre, nel proprio modo di rapportarsi agli altri, la coscienza delle proprie radici diverse. È in ragione di questa diversità, rimasta nonostante le vicende in cui la sua vita si è dipanata, e i successi che ha colto, che quella che racconta è «una storia operaia». Dove «operaia» non rimanda tanto a connotazioni di classe o di censo, quanto a un modo di porsi verso gli altri. È nello sguardo con cui li osserva, con silenziosa fierezza, con lentezza, direi: lo sguardo del ragazzino della portineria.
Libertà nel Palazzo
Era quindi quasi ovvio che chi sa guardare con tanta attenzione agli uomini, a come si muovono sotto le spinte degli interessi e delle passioni, finisse presto per occuparsi professionalmente del «personale», poi diventato «risorse umane», e quindi alla geometria delle organizzazioni aziendali. È stato in quel periodo, che costituisce la seconda parte del libro, che ci siamo conosciuti. Se il periodo in cui abbiamo lavorato insieme è stato breve (poco meno di due anni) e l’amicizia invece solida e duratura, dipende — faccio un azzardo — dal fatto che quello è stato un momento in cui tutti e due abbiamo goduto di una grande libertà: abbiamo sostanzialmente potuto fare, professionalmente, quello che volevamo. Anche perché entrambi eravamo, nel profondo e senza rendercene conto, uomini liberi. In Fiat il gioco di potere era nell’equilibrio tra Tufarelli e Beccaria. Il fatto che nel settore componenti, dove ero stato officiato direttamente da Umberto Agnelli, avessi smantellato definitivamente il disegno megalomane di Rossignolo, tranquillizzava i capi degli altri settori, le occhiute staff, l’azionista: il settore produceva utili. La competizione interna tra il costruttore di componenti e il produttore di «ruote» divertiva l’Avvocato. Io avevo, per la prima volta nella mia vita professionale, la possibilità di guidare una grossa macchina secondo i miei criteri; Riccardo Ruggeri aveva la libertà che voleva di provare sul campo modelli di organizzazione e di sviluppo. Il settore componenti, pur nella sua dimensione globale di poco meno di quarantamila persone, era costituita, oltre che dalla grande Magneti Marelli, da un gran numero di aziende medie, alcune anche piccole. Istintivamente, dagli anni in cui avevo lavorato nella società di famiglia, consideravo le aziende come fossero persone, persone che hanno il loro carattere, che sono esigenti, che vanno rispettate e capite. Riccardo aveva portato nella professione il suo innato interesse per le persone. Avevamo dunque lo stesso modo di rapportarci ad oggetti diversi. In quel periodo relativamente breve si è concentrata una grande accelerazione nell’evoluzione professionale. Poi le nostre strade si sono separate, e Ruggeri ha perfezionato, applicato e quindi teorizzato la sua specialità: costruire aziende a partire da uomini. Ma la decisione quasi istintiva, di pelle, con cui decisi di smantellare la struttura «command and control» che Rossignolo aveva iniziato a costruire, per gestire invece quel grosso, complicato e diversificato settore con una struttura di governo di una dozzina di persone, è la versione grezza di quella che Ruggeri porterà a perfezione, riuscendo a gestire, con un centro ridicolmente — rispetto a tutti gli esempi correnti — esiguo (20 persone ubicate in un modesto ufficio nella periferia di Londra), una multinazionale presente in 140 paesi, con una decina di marchi, 22 stabilimenti in 4 continenti, 32.000 dipendenti. Da parte mia, lo trasferii in Olivetti, nella gestione di quella che poi sarà Olivetti Information Services, le attività software e servizi dell’azienda informatica.
Il problema della governance, nella sua più ampia accezione, sia societaria sia aziendale, ritorna continuamente nelle riflessioni di Ruggeri, fino a costituirne uno dei fili rossi, l’angolo visuale dal quale guardare persone e situazioni. Perfino la Chiesa gli appare come una funzionalissima organizzazione a due livelli.
Questo è ovviamente il tema della seconda parte, il Palazzo: perché di che cosa si parla, nel Palazzo, se non del rapporto col Principe? che cosa si osserva se non il rapporto con gli altri Palazzi? Ma c’è anche, in modo forse ancora più esplicito, il tema della terza parte, dove la causa della «grande crisi» è individuata in un certo modello di management, e dove il modo di uscirne è indicato nell’abbandono del «pensiero unico» che l’ha prodotto. A ben vedere, anche nella portineria il giovane Riccardo aveva avuto modo di riflettere sulla governance, di questo parlano le due straordinarie frasi che riporta di suo padre, una in particolare: «Noi operai, a differenza dei borghesi, abbiamo la schiena dritta e siamo ricchi di valori veri, che difendiamo comunque, senza scendere mai a compromessi». Aveva poi visto in famiglia, in corpore vivo, che cosa in realtà significasse la governance operaia dei giorni della Fiat commissariata.
Capitalismi
Alcuni «ritratti» (e alcune vicende!) sono un ulteriore contributo alla storia del nostro capitalismo famigliare, ed al particolare modo con cui esso ha utilizzato gli strumenti di mercato, la Borsa in primo luogo. I giudizi su Giovanni Agnelli non sono teneri ma, secondo Ruggeri, sta nella sudditanza imposta da Enrico Cuccia e da Mediobanca la vera responsabilità per le vicende che hanno portato l’azienda che Valletta aveva fatto ricca di prodotti, di competenze, oltre che nei bilanci, al drammatico passaggio del «convertendo» e al fortunoso guizzo della famiglia per evitarne le conseguenze.
Eppure, nel risalire la concatenazione degli eventi, si può sempre aggiungere un anello in più. Non si capisce il ruolo di Cuccia senza collocarlo nel contesto di un paese che si era dato una Costituzione che, come riconosce Tommaso Padoa Schioppa, nella parte che riguarda l’attività economica sarebbe stata perfettamente compatibile con quella di una repubblica sovietica. Non lo si capisce senza ricordare che il Governo controllava tutto il credito, che la parte dell’economia intermediata dal pubblico era arrivata a superare il 50 per cento, che l’industria privata era stata abituata Fiat compresa — al protezionismo e alle commesse belliche, povera nelle idee, timida nelle scommesse.
Cuccia, attraverso tanti salvataggi, ha mantenuto in vita il particolare modello di governance del capitalismo delle grandi famiglie: ma che alternativa c’era, allora? E anche oggi, oggi che abbiamo una Consob e un’Antitrust, che Piazza Affari si è fusa con la Borsa di Londra, che il capitale finanziario è diventato mobile, che Cuccia non c’è più e Mediobanca da tempo ha perso la sua posizione unica, e raccoglie risparmio come una banca universale, ancora oggi il nostro capitalismo non ha né la robustezza calvinista di quello renano, né la vivacità schumpeteriana di quello anglosassone. Credo poi che nella difficoltà di Cuccia di comprendere Umberto Agnelli ci fossero anche ragioni di cultura politica, la diffidenza verso le posizioni che Umberto Scassellati elaborava nella Fondazione Agnelli, il ricordo della reazione di Umberto alla crisi dello Yom Kippur, quando qualcuno pensava che l’auto sarebbe finita e che la Fiat si sarebbe dovuta occupare di costruire autobus e ospedali.
In fondo era la stessa diffidenza di Cuccia (e che certamente provava Bruno Visentini) per le visioni comunitarie di Adriano Olivetti, e che si sommò a una probabile difficoltà culturale a comprendere la specificità dei prodotti e dei mercati in cui si muoveva l’azienda di Ivrea: tanto che il gruppo di intervento organizzato da Cuccia chiuse la possibilità per il nostro paese di avere un ruolo di primo piano nel business dell’informatica.
Per molte ragioni quel Palazzo non era un Palazzo qualsiasi, e proprio sui temi della governance. A livello societario, perché era il simbolo del capitalismo famigliare italiano. A livello aziendale, perché in tutto il mondo l’automobile è stato il luogo in cui si sono inventati e sperimentati i metodi della produzione di serie e i sistemi di organizzazione aziendale. I tre libri più importanti di teoria del management pubblicati nel secolo scorso, quelli di Peter Drucker, Concept of the Corporation, di Alfred Sloan, My Years at General Motors, e di Alfred Chandler, Strategy and Strutture, sono tutti sull’auto, anzi tutti sulla General Motors. Era stato Ford a tradurre in realtà la teoria del «management scientifico» di Frederick Taylor, che consentì di far produrre oggetti complessi da parte di operai senza specializzazione; ed è stato Alfred Sloan a creare l’impresa che poteva andare avanti senza dipendere da nessun individuo in particolare. Ronald Coase in The Theory of the Firm già nel 1937, nell’analizzare vantaggi e limiti della crescita dimensionale dell’impresa, aveva certamente di fronte anche la grande industria dell’auto. In Italia, in quel Palazzo, e nel vicino «pensatoio» di Marentino, ancor più dopo la organizzazione che aveva dato luogo alle 13 divisioni, di modelli di gestione di grandi strutture organizzative si discuteva parecchio.
Chi deve comandare?
La domanda non riguarda solo le imprese, ma in generale la società, civile e politica. La polemica sull’arretratezza della classe dirigente italiana precede l’unificazione: dal «fare gli italiani» di Massimo d’Azeglio alle riflessioni di Gramsci e Gobetti sulla inadeguatezza di élite immature a costruire la nazione. Non sono mai mancati, in Italia, i club degli ottimati, dalla «Rivoluzione Liberale» agli «Amici del Mondo» fino ai loro epigoni. Essi si sono sempre pensati come una falange di «migliori», sinceramente dediti al l’educazione del popolo, investiti di una visione del bene comune, e tuttavia stranieri nel proprio paese. L’élite che pensa se stessa come tale fa testimonianza, quella che si acconcia allo specifico del «paese reale», governa.
La principale eredità del Sessantotto, che ha giocato sull’annullamento del fossato scavato tra banco e cattedra, e sull’annullamento delle asperità di una società considerata eccessivamente verticalizzata, è stato l’egualitarismo generalizzato. Ma il «dentro tutti» con cui, dopo il decennio degli anni di piombo, i «rivoluzionari» sono stati integrati nella classe dirigente, ha paradossalmente chiuso ogni prospettiva di ricambio successivo. Nell’accademia, nel giornalismo, nella politica, la classe dirigente unisce un numero di vegliardi renitenti al pensionamento a schiere di cinquanta-sessantenni. I reduci del Sessantotto non hanno saputo proporre nessun filtro alternativo a quello che hanno smantellato.
Il paese è così diviso in due. Da un lato ci sono le gerarchie «di mercato», quelle che sono il risultato di criteri di selezione abbastanza simili a quelli invalsi in altri paesi occidentali. Al percorso formativo che prevede Mba presso un pugno di università che vendono nozioni e relazioni, alla transumanza nelle società di consulenza, all’approdo direttamente ai piani alti della gerarchia, Ruggeri dedica pagine di duro sarcasmo. Eppure tutto sta a indicare che la nostra classe dirigente imprenditoriale e finanziaria sia in linea, e a volte al di sopra, degli standard del resto dell’Occidente.
Dall’altro lato è in altri settori del paese che stanno i problemi maggiori: nella politica certo, ma prima ancora nei due principali canali della formazione di un’opinione pubblica, le Università e il giornalismo. Dovrebbero essere i luoghi del dinamismo, della vivacità, della sperimentazione: e invece sono gli spazi più sclerotizzati, metodicamente uguali a se stessi della società italiana. I meccanismi di selezione della classe dirigente erano interni ai partiti, secondo prassi e logiche oggi superate. La società civile sfociava nel partito politico, secondo percorsi segnati, in cui la rappresentanza degli interessi legittimi era scarsamente plurale. Dopo Tangentopoli, è invalso un sistema più pluralistico, ma senza che si sviluppassero strumenti di selezione simili a quelli presenti in altri paesi. Manca un sistema trasparente di aggregazione degli interessi, un sistema universitario competitivo, think tank e fondazioni che sappiano sviluppare visioni e modelli, reti di relazioni che sappiano congiungere pensieri e obiettivi anche differenti.
Vecchi palazzi
Quarant’anni fa iniziò il declino di Fiat, che pur conobbe «modesti successi parziali che ciclicamente si verificheranno, o per l’uscita di un modello di successo o per regalie dello Stato italiano». Così come conobbe anche alcuni grandi successi, primo fra tutti il turn around di New Holland, il capolavoro di Ruggeri.
Quarant’anni fa iniziò anche il declino di General Motors, fino alla bancarotta e al salvataggio da parte del Governo federale. Fallita è pure la Chrysler, con cui Fiat auto si gioca le ultime carte per la sopravvivenza. Intanto il mondo si dibatte nelle morse della più grave depressione da mezzo secolo. La tentazione di stabilire un nesso tra questi fatti è grande, ma credo che sia fuorviante. Le ragioni che hanno portato al fallimento Gm sono molto diverse da che obbligano Fiat a giocare carte azzardate per sopravvivere
il settore si razionalizza. Vw, ma anche Psa e Renault, dimostrano che è possibile guadagnare facendo auto in Europa. Toyota dimostra che è possibile farlo fabbricando in Usa. La grande crisi ha aggravato le condizioni di chi aveva problemi, ma le sue cause sono profondamente diverse da quelle che affliggono l’auto.
Ancora oggi non esiste un unico modello che spieghi la Grande Depressione del 1929. Non c’è da stupirsi se, per la crisi odierna, nessuno dei modelli esplicativi proposti risulta soddisfacente; anche se alcune spiegazioni possono essere abbastanza facilmente scartate. Su questo tema quindi, divergenze di opinioni sono ampiamente compatibili con la adesione allo spirito del libro e alla maggior parte dei giudizi che vi sono espressi. Io credo che le cause della grande crisi siano più generali e più profonde, e che diventeranno chiare con gli esiti che la crisi avrà. Non sono convinto che essa sia dovuta in modo determinante dal comportamento di banchieri e tanto meno di industriali.
Manager e investitori prendono decisioni nel quadro delle leggi e delle regole vigenti in quel momento. Se alla fine l’effetto cumulativo di queste decisioni dà esito negativo, allora l’accusa di irrazionalità va almeno ripartita con chi quelle leggi ha scritto. Cattive regole producono cattivi comportamenti. Non era irrazionale il comportamento di chi comprava una casa a debito. Non lo era quello dei banchieri: essi ben sapevano che se i prezzi delle case fossero scesi di un 20 per cento, molti di loro sarebbero falliti, e che la successiva recessione avrebbe aumentato le sofferenze dei crediti, tant’è vero che cercarono in tutti i modi di diversificare i rischi, producendo quelli che ora si chiamano prodotti tossici. Ma, osserva Richard Posner2, nessuna banca avrebbe potuto giustificare di fronte ai suoi azionisti una riduzione del rischio, e quindi dell’utile, solo perché questo avrebbe potuto provocare una crisi e quindi una successiva depressione: se l’avesse fatto avrebbe solo perso mercato a vantaggio dei suoi più audaci concorrenti, senza nessun vantaggio collettivo. Anche risparmiare di più durante una crisi, comportamento logico da parte di chi teme di poter perdere il proprio lavoro, se perseguito collettivamente, porta alla recessione: dovremo biasimare chi nella crisi non spende i propri risparmi?
Delle critiche che Ruggeri muove alla subalternità culturale dei consulenti, all’infatuazione per le scuole di management, alla tipica carriera del capo azienda, si è già detto. Ma si deve riconoscere che bisogna pur dare una risposta a quello che, soprattutto per l’Italia, è un problema centrale, separare proprietà e controllo, provvedere al ricambio generazionale, consentire alle nostre piccole e medie imprese di crescere. Del private equity non esistono solo le facilonerie presenti soprattutto nella sua degenerazione provinciale: è un formidabile strumento per eliminare le incrostazioni, per liberare business bloccati all’interno delle gerarchie aziendali. Per fare questo sono necessari manager, è necessario che quella del management sia una professione che si può insegnare. Abbiamo bisogno della teoria di Sloan sul management, ovviamente adattata alle nuove strutture aziendali e nazionali. Anche lo scettico deve credere che nel suo scetticismo stia la verità.
Nuove portinerie
«I periodi di crisi — scrive Ruggeri — sono democratici per la loro capacità di ridistribuire quote di mercato». La fase critica del capitalismo è la bolla, la crisi che succede al suo sgonfiarsi è il momento in cui il capitalismo dà il suo meglio. Per questo sono preoccupato per come i Governi stanno reagendo alla crisi: per impedire questo processo darwiniano. Negli Usa la politica del Governo è di usare tutte le ricette disponibili, e tutte in dosi massicce. In Europa invece prevale l’interesse a scrivere le regole che dovrebbe:: Impedire la prossima crisi. Ma poiché questa non si verificherà :ornarli, e dato che si è ancora lontani dall’avere un modello che spieghi persuasivamente il perché, e della crisi e della successiva depressione, la priorità data alla regolamentazione è rivelatrice di .:à altra priorità, quella di arrogarsi maggiori poteri nella allocazione delle risorse, nel dilatare l’area dell’economia intermediata dallo Stato.
Con il pretesto di promuovere una maggiore eguaglianza, invece di aumentare quantità e varietà delle opportunità, si riducono gli incentivi del mercato a produrle e le possibilità per i cittadini di coglierle. La persecuzione contro gli hedge fund, che non hanno provocato rischi sistemici, e che non sono costati soldi agli Stati, serve gli interessi delle banche che così mettono le briglie ad aggressivi concorrenti. La lotta ai paradisi fiscali serve gli interessi delle finanze dei paesi indebitati, che così eliminano la concorrenza di sistemi tributari meno oppressivi. Ogni intervento per imporre l’«ordine» del regolatore all’«anarchia» del mercato, favorisce alcuni interessi a danno di altri, pone le condizioni per la cattura del regolatore. Inesorabilmente, gli atti di Governo sono soggetti alla nemesi delle conseguenze inintenzionali.
La concorrenza e le economie di scala tendono a ridurre il numero dei player a poche aziende globali: è così nei veicoli industriali, nei trattori, negli aerei. A questa tendenza se ne è aggiunta un’altra, che non è frutto della concorrenza, ma della ricerca di protezione. Nelle banche il Governo pensa a dare uno status speciale a una dozzina di megabanche, che ha salvato e che vuole poter controllare. Succede per le banche, potrebbe succedere per le assicurazioni; sta forse succedendo, in modo analogo, nel settore dell’auto. Sembra che sia in atto un processo per cui alcuni prodotti e alcuni servizi diventano delle commodity, forniti da aziende protette, intrusivamente regolate, indotte a fornire prodotti sostanzialmente indifferenziati. Una prospettiva non esaltante: tutto congiura a rendere queste imprese rigide nell’innovare, arroganti nei rapporti con i consumatori, pesanti nelle gestione. Finirà che rimpiangeremo il sistema che dava bonus milionari ai top manager di imprese paranoiche nella persecuzione del profitto.
Chi ha fiducia nel capitalismo schumpeteriano, vede in questa situazione grandi opportunità per i new entrant, che, partendo dal basso, e senza scopiazzare i modelli esistenti, disegnano strutture aziendali snelle, che servano non al mantenimento dello status quo, ma alla sola cosa per cui esistono, soddisfare le esigenze dei consumatori. Non sarà facile, perché le regole per evitare che la storia si ripeta (cosa che tra l’altro ha l’abitudine di non fare), saranno scritte in modo da proteggere i grandi fornitori di commodity, e perché questo riguarda anche l’erogazione del credito e la diffusione delle informazioni, nonostante la pervasività dei new media. Non sarà neppure breve.
Sorregge pensare che infinita è la capacità combinatoria della vita. Che nel grande mondo, ci sono molti ragazzini, che, da una portineria, guardando gli andirivieni dei grandi, «senza alcun motivo, forse la spocchia, li trova tutti antipatici, padroni e servi».
Molte di quelle portinerie non sono più in Occidente.







settembre 1, 2009