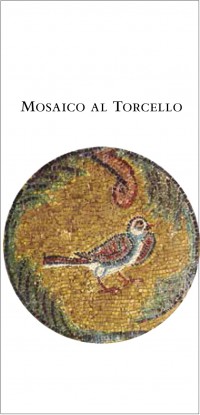
Mosaico al Torcello
Per il matrimonio di Anna Giavazzi e Giovanni Zevi della Porta
1° Giugno 2014
Epitalamio, Anna, si fa presto a dirlo! Il passato remoto intimidisce – Saffo, Catullo. Il tuo Parini lo si può leggere solo più come una parodia.
E pur dolce in su i begli anni
De la calda età novella
Lo sposar vaga donzella,
Che d’amor già ne ferì.
Epitalami ce ne sono anche di moderni. Splendido Neruda.
Recuerdas cuando en invierno llegamos a la isla?
Ma è qualcun altro che deve ricordare con te cosa successe sull’isola. Meglio fermarsi qui: anzi, meglio lasciar perdere. Meglio parlare del tempo. Oltretutto del matrimonio il tempo è, per così dire, il campo.
C’è il tempo passato, è stato il tempo dell’attesa. I sette anni che Giacobbe dovette attendere, pascolando le greggi di Labano, prima che gli venisse concesso di generare figli con Rachele. Poi a lui non andò esattamente così: ma qui, quanto a stato civile, andiamo sul sicuro.
Quanto ai sette anni, bisognava cominciare a viverli. Sarebbe stato più facile passarli dormendo. Tuttavia non solo perché ciò non era possibile ma anche perché, tutto sommato, era meglio passarli ad occhi aperti lavorando, un tal desiderio nemmeno gli venne.
La tradizione narra infatti che quegli anni, tanto temuti in principio, poi passarono per lui come singoli giorni [...]. Non si trattava di qualche sonno favoloso o di qualche altra magia se non della magia stessa del tempo, le cui grandi unità passano come le piccole, né presto né adagio, ma passano: semplicemente. [...] Un anno non consiste soltanto nel giro delle sue stagioni [...]. Un anno è solo una cornice, una grande filigrana di vita, tutta fitta di eventi, un mare da bere. Anche il giorno, anche l’ora — in proporzioni minori, se si vuole — formano una filigrana di pensieri, di sentimenti, di azioni, di fatti. [...]
Nessuno afferma che Giacobbe abbia iniziato i sette anni con gioia, poiché solo al loro termine gli sarebbe stato permesso di generar figli con Rachele. Ma questo era solo un dolore riflesso, un dolore del pensiero e veniva in gran parte indebolito e annullato dalle reazioni puramente vitali che determinavano il suo rapporto col tempo e del tempo con lui. Giacobbe doveva vivere centosei anni e, se non sapeva ciò con lo spirito, lo sapevano tuttavia il suo corpo e l’anima della sua carne. In tal modo i sette anni non erano davanti a lui così pochi come davanti a Dio ma nemmeno tanti come per chi debba vivere solo cinquanta o sessant’anni, e la sua anima poteva guardar tranquillamente questo tempo di attesa.[...]
Quando tornava a casa per rendere conto al padrone del numero e dell’accrescimento del gregge e per far sfilare le pecore davanti a lui sotto il suo bastone, egli vedeva Rachele che, come lui aspettava nel tempo. E, mano nella mano, si appartavano in qualche luogo dove nessuno li vedesse e parlavano con passione della loro sorte, e quanto tempo ancora dovevano aspettare. [...] E talvolta era lui a consolare lei, talvolta lei che consolava lui. Ma perlopiù era Rachele che doveva essere consolata, perché il tempo per lei era più lungo e più duro a sopportare per la sua anima. [....] Allora Giacobbe prendeva la testa di lei tra le mani e la baciava sotto i due occhi le portava via le lacrime con i baci così che le sue labbra ne erano bagnate, e diceva: «Oh, mia piccola, buona, giudiziosa Rachele, pecorella impaziente, fatti coraggio! Guarda, io prendo queste tue lacrime con me nel campo e nella solitudine come pegno e garanzia che sei mia, a me promessa, e che con pazienza e impazienza aspetti me, come io aspetto te. Poiché io ti amo e la notte dei tuoi occhi mi è cara più di ogni altra cosa al mondo e il calore del tuo capo, quando l’appoggi sul mio, mi pervade fin nel più profondo. I tuoi capelli hanno la serica mollezza e lo splendore che ha il vello delle capre sui pendii di Ghilead, bianchi come la luce sono i tuoi denti e le tue guance mi ricordano vivamente la delicatezza della pesca. La tua bocca è come i giovani fichi quando si arrossano sull’albero e se io la chiudo con i miei baci l’alito che esce dalle tue narici ha il profumo della mela. [...] Tu sei pura di sangue, o mia diletta, e le malattie non ti colpiranno e nessun demone ti toccherà. Il Signore, il mio Dio, che mi ha condotto a te e ti ha serbato per me, lo impedirà. Quanto a me, sappi che il mio amore e il mio affetto per te sono indomabili e una fiamma che nemmeno le piogge di molti anni potranno estinguere mai. Penso a te quando sto sdraiato all’ombra della roccia o del cespuglio o sto appoggiato al mio bastone o quando giro qua e là in cerca della pecora smarrita o curo la malata o porto lo stanco agnello, quando affronto il leone o attingo acqua per il gregge. Nel far tutto questo io penso sempre a te, e così ammazzo il tempo. Il tempo passa, infatti, incessantemente qualunque cosa io faccia, e Dio non gli concede di fermarsi neppure un momento, sia che io riposi o mi muova. Tu e io aspettiamo nel vuoto e nell’incertezza. Noi conosciamo la nostra ora e la nostra ora conosce noi ed essa viene verso di noi. Ma per certi riguardi non è forse male che tra essa e noi ci sia ancora un certo tempo, perché quando sarà venuta noi ce ne andremo di qui nel paese verso cui emigrò il primo padre e sarà bene che per allora io diventi ricco facendo buoni affari, affinché si adempia la promessa del mio Dio, che vuole ricondurmi ricco in patria, nella casa di Jizchak. [...]
C’è il tempo futuro, sarà il tempo dei ricordi. Come nei sei versi che Thomas Mann ha incastonato nel “brindisi” a Katia per il suo 70esmo compleanno.
Nel fido porto fu cominciato
Poi nell’esilio l’ho continuato
Ora ho mancato, ora ben lavorato
Sol col tuo aiuto fu terminato
Su questa terra restami a lato
E tutto alfine sarà terminato
Angefangen am trauten Ort
Schrieb in der Fremde daran fort.
Einmal fehlt ich, macht’s einmal gut
Es wurde fertig in Deiner Hut.
Bleibe Du mir auf dieser Erden,
So soll alles fertig werden!
E c’è il sentimento del tempo, delle generazioni che vi hanno preceduto, di quelle che vi seguiranno. Dei Mann, lui era il gentile, ebrea la moglie. Nel 1918, quasi 10 anni dopo il terzo figlio, nasce Elisabeth, e lui le scrive un idillio in versi. Il Gesang vom Kindchen non è mai stato tradotto in italiano: il pezzo che ne ho estratto è una prima assoluta.
Da ragazzo, a Natale, piluccavo il cibo delizioso, noto in tutto il mondo, la torta a cui i nostri pasticceri davano la forma della porta turrita della città. E’ fatta di manna, vien dall’oriente, una prelibatezza da harem, ha il sapore di mandorle, d’acqua di rosa e di zucchero: battezzata a San Marco, da Venezia è giunta fino a noi. In spagnolo si chiama Mazzapan, massepain in francese – ma in ebraico sarebbe mazzoth, il dolce di Pasqua del popolo che attraversa i deserti, del popolo disperso, del popolo di mezzo tra oriente e occidente.
Come a Venezia, per la prima volta, nel sogno e nel piacere, mi balzò il cuore in petto, così fu dieci anni dopo, quando in una sala dorata mi accorsi dell’immagine della fanciulla, di colei che ora è la tua mamma, la principessa d’oriente a me destinata attraverso i tempi. I neri capelli coronati d’oro le cadevano sulle spalle d’avorio, spalle di fanciulla, diverse da quelle delle nostre donne, spalle di suonatrici di flauto, spalle della valle del Nilo, e poi scendevano sulla rossa veste.
La sua seria piccola faccia straniera aveva il candore delle perle, i suoi grandi occhi parlavano una lingua oscura. Fiaba del levante! Sogno della terra d’oriente! In quel momento, bambina mia, quando nella giovanile esultanza posai il mio occhio sulla sua dolce figura, allora venne la tua sorte, e ti chiamò attraverso i tempi: perché io da uomo desiderai quella che avevo visto, lavorai duro, e alla fine, come avevo voluto, la portai a casa.
E ora guardando te, penso di patria in patria, amore mio che hai le sopracciglia dei padri ed il piccolo naso moresco. Patria più profonda è l’oriente, patria dell’anima, patria dell’uomo, patria della più antica, della più mite saggezza. Non è forse incontrando l’oriente che uno spirito nordico creò quel libro potente, che al mondo parla della volontà e della rappresentazione, e che unisce la forza del pensiero tedesco con i segreti dell’Upanishad?
E così ora nel mio sogno abbraccio te, l’essere che mi è umanamente più vicino: te, bambina mia, e il patrimonio spirituale che ho ereditato e che conservo, consolazione nella vita e nella morte; e mi siedo vicino al cesto sul Nilo, faccio la guardia e tengo la tua manina, osservando il tuo viso e la sua conformazione speciale.
In una festa di matrimonio c’è sempre una certa disparità di genere. Per rompere il soffitto di confetti e panna montata, il pezzo finale è per Giovanni. C’è un personaggio, nel Sogno di una notte di mezza estate, che mi ricorda le sfuggenti particelle esotiche a cui Giovanni dà la caccia nei tunnel di Ginevra: Puck. Con qualche variante per la circostanza sia Puck e disporre l’ultima tessera di questo mosaico al Torcello.
Se vano e insulso è stato questo dire,
gentile pubblico, faremo ammenda;
con la vostra benevola clemenza,
rimedieremo alla nostra insipienza.
E, parola di Puck, spirito onesto,
se per fortuna a noi càpiti questo,
che possiamo sfuggir, indegnamente,
alla lingua forcuta del serpente,
ammenda vi farem senza ritardo,
o tacciatemi pure da bugiardo.
A tutti buonanotte dico intanto,
finito è lo spettacolo,
ma durerà l’incanto
Signori, addio, battete lor le mani,
e Robin v’assicura che domani
migliorerà della sua parte il canto.
Leggi il libretto completo del Mosaico al Torcello
di Franco Debenedetti







giugno 1, 2014