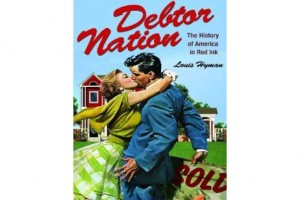
Debtor Nation: The History of America in Red Ink
by Louis Hyman
Choice’s Outstanding Academic Books, 2011
pp. 392
Before the twentieth century, personal debt resided on the fringes of the American economy, the province of small-time criminals and struggling merchants. By the end of the century, however, the most profitable corporations and banks in the country lent money to millions of American debtors. How did this happen? The first book to follow the history of personal debt in modern America, Debtor Nation traces the evolution of debt over the course of the twentieth century, following its transformation from fringe to mainstream–thanks to federal policy, financial innovation, and retail competition.
leggi il resto ›
![]()
di Lorenza Sarzanini
Soldi del partito utilizzati per acquistare un appartamento al centro di Roma e altri beni personali. Ben 13 milioni di euro della Margherita che l’ex tesoriere del partito è accusato di aver dirottato su società italiane ed estere. Si tratta di rimborsi elettorali e di altri finanziamenti provenienti dal Partito democratico, ma Luigi Lusi – tuttora senatore del Pd – li avrebbe gestiti come se fossero suoi. Per questo è indagato per appropriazione indebita dalla Procura di Roma, ma l’inchiesta non è terminata.
leggi il resto ›
![]()
dby Philip Stephens
I keep hearing people say don’t blame the rating agencies. My first reaction is why not? After due and sober reflection my considered response is why the hell not?
leggi il resto ›

di Cesare Cavalleri
Vilfredo Pareto (1848-1923), oltre che economista e sociologo, è anche un ottimo scrittore, il che non guasta. Appartiene alla schiera degli economisti “marginalisti” il cui capostipite è Léon Walras, al quale Pareto succedette nella cattedra di economia dell’Università di Losanna, nel 1894. Sia Pareto, sia Walras provenivano da studi d’ingegneria.
leggi il resto ›
![]()
Torna il libreria il trattatello liberale e libertario di Pareto. Un libro che nel mettere a nudo le ipocrisie dell’epoca, denuncia i rischi che si nascondono dietro ogni moralismo proibizionista che, oggi come un secolo fa , pretende di vietare irrinunciabili diritti personali dell’individuo
È una iattura il trionfo del conformismo moralista. Anzi, quando i moralisti assurgono a maître à penser di un’epoca la dittatura è dietro l’angolo, per quanto soft e mistificata da buonismo possa essere. E mentre si diffonde questa potente arma di distrazione di massa le classi dirigenti dimenticano i veri problemi del Paese. Ci hanno provato in tanti, soprattutto nella stagione del berlusconismo declinate, a dare una lettura assolutoria delle macerie contemporanee al libretto che Vilfredo Pareto scrisse nell’eremo di Célignymentre si accingeva a dare l’ultima versione alla sua opera più ponderosa e sistematica, il Trattato di sociologia generale. Ora di questo trattatello, pubblicato in Francia nel 1911 (Le mythe vertuïste et la littérature immorale) e tradotto con notevoli integrazioni in Italia nel 1914, è uscita una riedizione per iniziativa di Franco Debenedetti e dell’editore Liberilibri.
Con il termine «virtuismo» Pareto intende sviluppare una critica verso i censori moderni, che si ergono a paladini della morale pubblica a detrimento delle più elementari espressioni della libertà individuale. Per alcuni può essere definito «libertario», un intellettuale consapevole della trasformazione dei valori morali, e della loro opinabilità alla stregua della religione e della politica. Un antiproibizionista ante litteram, in particolare contro le limitazioni legislative alla letteratura cosiddetta immorale di cui fu portavoce il presidente del Consiglio dell’epoca Luigi Luzzatti.
Sulla scia di questo principio Pareto dà alle stampe il volume, che fu dettato dalla curiosità per i fatti contemporanei e dall’interesse che egli mostrava per la cronaca nera e giudiziaria. Anzi si può affermare che il libro nacque dall’attenzione che Pareto rivolse al romanzo Quelle signore (1904) e al processo che il suo autore Umberto Notari (1878-1950) subì per oltraggio al pudore nel 1906 e nel 1911. Le due sentenze si ritrovano nell’edizione del 1914 e sono riportate in quella del 1966, insieme alla Circolare Luzzatti sulle pubblicazioni pornografiche: «Qui riproduciamo la sentenza di uno di questi processi in cui si vedrà incriminata la riproduzione di ”due brani tolti una dalla Bibbia e uno dal Dialogo delle prostitute di Luciano”».

di Alessandro De Nicola
Le privatizzazioni e le liberalizzazioni sono il nerbo delle riforme strutturali necessarie a rilanciare la nostra economia. Servirebbero a ridurre debito e sprechi e anche a frenare la corruzione. Ma il mito della proprietà pubblica è duro a morire
Consoliamoci, la manovra economica del governo non è la fiera di tasse esotiche che avrebbe potuto diventare. Tuttavia uno dei suoi capitoli più oscuri rimane quello delle privatizzazioni che, insieme alle liberalizzazioni, sono il nerbo di quelle riforme strutturali che potrebbero rilanciare l’economia del nostro paese.
Il mito della proprietà pubblica è duro a morire perché non nasce con il marxismo ma è profondamente radicato nella storia e nella cultura del Bel Paese. Dall’ager publicus romano alla Cassa Depositi e Prestiti, sono cambiate le motivazioni per le quali lo Stato possiede e si cimenta nella gestione di attività economiche, ma la sua ingombrante presenza è sempre lì.
Vediamo di riassumere brevemente perché privatizzare è invece una scelta politica virtuosa per l’Italia.
Prima di tutto bisogna ridurre lo stock del debito pubblico. Sappiamo che ha raggiunto il 120 per cento del Pil e che la spesa pubblica è il 50,8 per cento del Pil: in queste condizioni la vendita di aziende e immobili ai fini sia della riduzione del debito che degli interessi passivi pagati dallo Stato italiano ai sottoscrittori dei suoi titoli è indilazionabile. A seconda delle stime, un programma massiccio di dismissioni sia di imprese che di immobili pubblici (statali e degli enti locali) potrebbe portare a ricavi tra i 250 e i 300 miliardi di euro, sufficienti per riportare in breve tempo il debito pubblico sotto il 100 per cento del Pil senza bisogno di patrimoniali. Inoltre, si risparmierebbero almeno altri 10 miliardi di interessi, l’equivalente di una manovra (basti pensare che l’aggiustamento dei conti compiuto con il decreto di ferragosto, portava ad aggiustamenti per il 2012 di appena 5 miliardi). E’ vero che si verrebbero a perdere i dividendi delle imprese che fanno profitto, ma nel corso degli anni clamorose son state pure le perdite (Tirrenia ed Alitalia insegnano).
L’obiezione che in questo momento le società quotate non sono valorizzate adeguatamente non regge. Prima di tutto anche i titoli di Stato pagano interessi elevati (oltre 300 punti di spread con il bund tedesco) e poi solo il mago Merlino sarebbe in grado di indovinare il momento giusto.
Altra obiezione, più sensata, è che le privatizzazioni dovrebbero andare di pari passo con le liberalizzazioni. Anche in questo caso è facile obbiettare che finché lo Stato è proprietario le liberalizzazioni sono più difficili e Poste e Ferrovie ne sono un esempio attuale. Peraltro, gran parte di ciò che si può vendere compete già sul mercato con i privati.
Il secondo punto parte proprio da questa constatazione: lo Stato fa concorrenza sleale ai privati. Le imprese pubbliche hanno un accesso facilitato al credito (almeno fino ad oggi la garanzia del governo vale qualcosa) ed in più sono vicine sia al legislatore che al regolatore. Controllati e controllori rispondono in ultima istanza allo stesso potere politico che li ha nominati.
Tale contiguità ci porta alla terza ragione per la quale il Leviatano dovrebbe spogliarsi dei suoi beni. Le scelte manageriali delle sue aziende, infatti, vengono più di qualche volta influenzate da motivi di convenienza elettorale, non di efficienza. Si tratti di assunzioni di raccomandati, di privilegi ai sindacati interni, di investimenti in collegi elettorali sensibili, di conclusione di affari con società amiche, sempre di sprechi stiamo parlando e le cronache dei giornali traboccano di esempi di “prossimità” tra faccendieri e imprese pubbliche.
Il che ci conduce al quarto punto: dove ci sono sprechi, intrusioni politiche, opacità, lì prospera la corruzione, piaga che non casualmente affligge così tanto il nostro Paese dove quasi tutto è intermediato dalla politica. Non è vero, come si illudono alcuni, che la proprietà di un’azienda o di un bene sia indifferente, purché funzioni. La politica non maneggia soldi suoi e ne ha meno cura, difficilmente viene sanzionata elettoralmente per cattiva gestione e, controllando il potere economico, può minacciare le fondamenta della democrazia. D’altronde, come ammoniva Ludwig von Mises, a cosa servirebbe la libertà di stampa se lo Stato possedesse tutte le tipografie?






